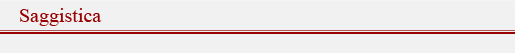
Presentazioni per La Casa dei sentimenti
Sergio Zavoli
presidente della RAI
Una strada da percorrere
Ciò che la RAI-Radiotelevisione Italiana ha voluto dire attraverso un programma come “Farsi uomo – oltre la droga”, da cui è tratto questo libro, ha molteplici motivazioni.
E’ un discorso di civiltà, essenziale in un movimento di crisi dei valori come quello attuale, in cui la droga semina stragi nel mondo dei corrotti, dei disponibili per debolezza, dei frastornati dalla miseria, dagli inseguitori di parvenze, dei privi di identità. La televisione può e deve affrontare il tema della droga opponendo argomenti di civiltà, offrendoli al dialogo, al giudizio e alla speranza; può e deve diffonderli là dove altri mezzi di comunicazione di massa hanno spesso toccato soltanto la corda dello scandalo senza motivazioni, della disperazione senza uscita.
E’ quindi un discorso di conoscenza e di denuncia, di educazione e di riscatto. Esso può evidenziare i legami tra una situazione privata, in cui troppo spesso si abbatte sul drogato il timbro a secco della criminalità o della malattia, e una condizione sociale di altro segno, dove i termini del profitto trascinano e trasformano a proprio piacimento il fenomeno e le situazioni che crea. Questo collegamento, di norma, la gente non lo fa; e nessun mass-media lo abitua a farlo.
Il coraggio di ex tossicodipendenti e di operatori che portano allo scoperto il problema, la disponibilità altrettanto coraggiosa delle famiglie a operare all’interno di sé immedesimazioni e realismo spesso difficili, una più persuasa e corale capacità di comunicare, possono moltiplicarsi proprio attraverso l’immagine e la parola trasmessa. La RAI ha proposto il “programma” come una strada da percorrere con le emozioni e i lati ragionativi di un diario privato. Questo diario, per merito della ERI, è diventato un libro, nel quale ogni lettore ha modo, senza pregiudizio, quanto meno di verificare quel cammino, affrontandolo col proprio passo morale e civile, spirituale e politico. Sarebbe, altrimenti, un viaggio nel niente.
Pierpaolo Donati
professore ordinario di Sociologia della famiglia all’università di Bologna
Alla ricerca di una cultura della vita
1 – Chi leggerà questo testo non potrà uscirne indenne, umanamente parlando. Non solo lo leggerà, probabilmente, tutto d’un fiato, ma soprattutto dovrà misurarsi con interrogativi molto profondi circa l’autenticità delle proprie idee e dei propri sentimenti. Non si tratta di cedere ad alcun “umanitarismo” o sentimentalismo, o cose simili. Si tratta piuttosto di accettare di rimettere in discussione la coscienza di sé alla luce della sfida radicale che proviene da un’esperienza umana “liminale, che sta al confine insondabile tra la vita e la morte, la quale si presenta oggigiorno di continuo davanti e in mezzo a noi. Si scoprirà allora che c’è più vita e intelligenza nella comunità di Castelgandolfo che in tante nostre cosiddette “famiglie normali”, dove spesso la vita e l’intelligenza vengono spente o attutite e rese ottuse da terribili dinamiche di indifferenza, di negazione della personalità dell’altro, dall’inautenticità dei sentimenti, insomma dalla chiusura a orizzonti di vita.
Non si prenda questa affermazione come esaltazione di uno spontaneismo vitalistico o di una “devianza intelligente”. Al contrario, il materiale accuratamente raccolto, ordinato e interpretato da Maricla Boggio, secondo percorsi densi di “senso prospettivo”, per dirla con Paul Ricoeur, dimostra che è proprio da esperienze liminali come quella della droga che proviene una esaltante, anche se tanto drammatica e dolorosa, ricerca di una nuova cultura della vita. Cultura non spontaneistica, ma capace di padronanza di senso, non intelligentemente deviante, ma significativamente ricentrata sull’uomo. E’ quanto vorrei mostrare, rifacendomi ai materiali del libro.
“ – Prendiamo innanzittutto la definizione e l’identità del tossicodipendente.Nelle dinamiche della vita ordinaria, nelle quali tutti noi siamo immersi, il “drogato” è un individuo che crediamo di poter ben identificare, tanto che – quando lo si è scoperto – lo si isola, lo si etichetta negativamente, lo si stigmatizza come un essere patologico. La nostra cultura crea e rafforza una definizione della persona dipendente dalla droga come “deviante” che deve essere semplicemente respinto o risocializzato a una non meglio definita “normalità”.
La comunità del Ce.I.S. parte da un assunto radicalmente opposto. Per essa, un ragazzo tossicodipendente è “un uomo che ha un problema in più. Non c’è niente di diverso” ( don Mario Picchi). “Un drogato è una persona che non si è mai rivelata a se stessa”, che “si nasconde con l’eroina” (Vito).“Il tossicomane – dice Lucrezia – è una persona che generalmente non è mai stata in grado di gestire quello che sentiva, qualunque sentimento esso fosse”. Alla luce di un tale approccio la tossicodipendenza diventa una dimensione della vita quotidiana ordinaria di tutti noi. Dell’uomo, in condizione corporea maschile o femminile, come tutti noi siamo. La prima cosa, dunque, che la comunità ci insegna è che la risposta della nostra cultura quotidiana alla droga è del tutto insufficiente e fuorviante: è una risposta difensiva, che nasconde precisamente il marcio che ha di dentro, proprio come modo di pensare e di vivere che “crea” la droga e incentiva processi di tossicodipendenza senza saper trovare verso di essi altro che risposte di rimozione, di negazione, di emarginazione.
La ricerca di una cultura della vita adeguata alle sfide odierne parte da qui. Parte dal capire che il drogato non è un essere “diverso”. I ragazzi lo comprendono. Chiede Arturo: “Chi è di voi che si sente o si è sempre sentito diverso?(Molte mani si alzano fra i ragazzi del gruppo) Anch’io – risponde Arturo – mi sono sempre sentito un diverso. Era la scusa più bella per fare quello che volevo io!”. In realtà il drogato non è un individuo alieno, ma piuttosto il prodotto – per così dire necessario e del tutto legittimo – di un’intera cultura “sbagliata” che produce noia, angoscia e senso di morte.
La tossicodipendenza non è differente da tanti altri fenomeni, sparsi ovunque nella nostra società. E non c’è bisogno di ricordare l’alcoolismo o la mancanza di autocontrollo di tanti soggetti socialmente e psicologicamente deboli. Si è “drogati” se e nella misura in cui si ha a che fare con un mondo di problemi che ci legano all’incapacità di vivere una vita padroneggiata con senso pieno, e senso umano. La nostra cultura, quella dell’odierna “normalità”, non ha risposte a queste istanze. Neppure riesce a comprenderle, benché le generi. Essa si rifugia nel “pensiero debole”, nella semplice presa d’atto che il soggetto-uomo non ha più un centro fondante, né ha più dimora in alcun centro. Assenza di fondamento e fine di ogni progettualità: manca ogni futuro. Perciò spezza ogni legame. Il che porta tutti a tenersi dentro il rospo,senza poterlo mai buttar fuori. E così i legami non vengono affatto superati, ma interiorizzati a un livello ancora più profondo e vincolante. Al contrario, la “casa dei sentimenti “ crede nell’uomo, ha un futuro e perciò può fondare il suo “progetto uomo” che tratta appunto il tossicodipendente non come un diverso, ma come una persona che, come tutti noi, ha bisogno di buttare fuori il suo rospo. “Il problema – dice don Mario Picchi – non è mai per nessuno il problema della droga: il problema è riscoprirsi “. Di qui, allora, riparte una cultura per la quale, “quando si prende coscienza della propria debolezza, si riesce ad aiutare gli altri” (Luigi).E se “sento di ‘poter dare ’, questo è un fatto che mi rende vivo” (Rinaldo). Si noti: non mi fa “sentire”, ma mi rende vivo.
3 – E veniamo al perché e al come si diventa tossicodipendenti.
La caratteristica della comunità di don Mario Picchi è cercare di capire le ragioni ‘ personali’ che portano al cammino della droga. Si tratta, infatti, di svelare cosa c’è dietro l’opacità del mero istinto del piacere, sulle soglie del quale si ferma la coscienza puramente emozionale del giovane.
La comunità di Castelgandolfo non ignora certo che esistono ragioni strutturali, macrosociologiche, in primo luogo la disoccupazione giovanile e lo sfruttamento, che portano al diffondersi della droga. Ma il perché e il come si diventa tossicodipendenti deve essere reso cosciente e vivido per ogni singolo itinerario, senza rimandi ed evasioni troppo astratte, giacché solo così ogni “me” diventa un “io”.
Si comprende, allora, perché da questi racconti emerga prepotente il ruolo mancato, e anche perverso, della famiglia e delle altre agenzie della socializzazione primaria e secondaria. L’analisi potrebbe farsi qui davvero impietosa. Ma non si sa se avere più pietà per i ragazzi o per i loro genitori. Si tratta, in genere, di famiglie con una struttura organizzativa ed emozionale assai debole, talora quasi assente, talaltra assai intricata. Ma il più delle volte si tratta di famiglie apparentemente “normali”. La qualità che le accomuna è l’estrema ‘rigidità’ nei comportamenti, negli atteggiamenti, nelle modalità interazionali, derivante non tanto dalla posizione rigida che occupano nel mercato del lavoro ( come alcune ricerche hanno asserito), ma soprattutto del fatto che ‘mancano quasi completamente di “riflessività”. Non riescono in nessun modo a riflettere su se stesse, a prendere coscienza di ciò che accade nel loro sistema relazionale e quindi a adottare cambiamenti e strategie adeguato. Mancando totalmente di un’idea-progetto di uomo interiore, mancano di autentiche relazioni fra uomini. E’ per questo che anche le famiglie di classe media o borghese, certo meno punitive e meno superficiali con i figli di quanto non siano le famiglie operaie, anzi assai sollecite nel dare ai ragazzi il denaro per comperare la droga, sono incapaci di un vero aiuto e risultano, alla fine dei conti, anch’esse “rigide”, pur nell’apparente modernizzazione dei loro valori e atteggiamenti.
“Ringrazia mamma che sei tornato, perché se era per me potevi pure rimanere in mezzo alla strada”, è un ritornello che si sente spesso nelle famiglie, e che rivela profonde e tremende dissociazione interne. Dal rapporto di ricerca emergono tanti tipi di dissociazioni e rotture. Il lettore avrà modo di esaminarle una per una. Ma indubbiamente c’è un filo rosso che le connette, e questo è la ricerca effettiva. Ascoltiamo Giuliana che incontra la madre dopo dieci mesi passati in comunità: “ Ci sono tante cose che mi hanno fatto male, soprattutto quando ero piccola, nel rapporto con te, mamma: Ho dei brutti ricordi di quando ero piccola, nel rapporto con te, mamma: il fatto di dover stare sempre sola a casa, perché tu andavi a lavorare…Ho dei brutti ricordi di quando ero piccola, stavo sempre in casa da sola. Ricordo quando andavo a giocare con dei bambini nel giardino sotto casa, alle quattro le madri li chiamavano affacciandosi, per fare merenda. Io guardavo il balcone di casa mia, non c’era mai nessuno. Andavo a casa di qualche altro bambino oppure andavo in un negozio dove potevo comperarmi quello che mi pareva…Non pagavo, avrebbe poi pagato mia madre, la conoscevano, era il suo negozio. Invidiavo gli altri bambini, li invidiavo anche quando tornavo a casa da scuola e sentivo che loro rientravano a casa e c’erano le madri, c’erano le radio accese in casa… odore di cibo che veniva dalle porte aperte… e invece in casa mia no, niente c’era, casa mia era vuota, silenziosa, senza odori, sembrava una casa disabitata… Aspettavo che mia madre tornasse, aspettavo che tu tornassi. ( Si rivolge alla madre, che ascolta attenta, senza interrompere).Tu dicevi un’ora che saresti tornata; io guardavo questa sveglia verdina che avevamo in casa, e quando arrivava l’ora che mi avevi detto, io mi sedevo sui gradini della scala, vicino all’ascensore, e aspettavo. Spesso mi addormentavo lì”.
Ed era lì, evidentemente, che cominciava il triste e consolatorio sonno dell’evasione. Certo non tutte le famiglie presentano questa desolante immagine. Le famiglie benestanti hanno altri mezzi e sostegni se la madre lavora. Ma le mancanze di affetto provengono da tante cause. Ascoltiamo il padre di Angelo: “Una sera venne, suonò il campanello, era “fatto” come una pigna.‘Ti ho detto che in queste condizioni non ti voglio più vedere, tu per me risulti un estraneo, non sei più mio figlio, non ti accetto più come figlio in queste condizioni ’.Lui mi ha detto: ‘Bè, allora questa sera hai perso un figlio’ ”. L’incapacità di dialogare porta la famiglia e le relazioni interpersonali a una situazione di “blocco”. Ed è evidente la prima responsabilità dei genitori, soprattutto dei padri. Dice Giancarlo: “Io avevo paura di affrontare questo discorso con mio padre, cioè di affrontarlo proprio faccia a faccia, a viso aperto, perché sentivo che lui mi schiacciava, che lui era più forte di me, in qualsiasi mio movimento io mi sentivo bloccato da lui”.
Con tutto questo la dinamica familiare resta un mondo simbolico e materiale ineludibile di riferimento. In ciascuno persiste uno sconfinato bisogno di affetto, di legami significativi in cui identificarsi positivamente. Vittorio (l’operatore) chiede a Vanni, che si è tagliato le vene nel tentativo di suicidarsi: “ Perché l’hai fatto in camera, nella casa di tua madre?Perché vuoi essere continuamente attaccato a lei?”. La verità è che la famiglia resta il referente primario dell’identità personale, ineludibile e unico: “ritorno da mia madre, perché è l’unica!”.
Queste dinamiche psicologiche e sociali sono ben note, come è noto il ruolo attrattivo del gruppo dei pari che si “sostituisce” agli affetti familiari. Non è il caso di insistere, né di farvi sopra teorizzazioni ormai conosciute. Ma un insegnamento è chiaro: il tossicodipendente mostra una struttura interiore fragilissima perché è la famiglia ad essere fragilissima. La famiglia, “in primis”, ha fallito. I genitori, quando ne prendono coscienza, sono portati subito ad autocolpevolizzarsi.Ma è una strada impropria, oltreché impietosa. Semplicemente non sapevano nulla, erano completamente impreparati: ma non di fronte alla droga, di fronte alla vita. Così, da queste storie, emerge ancora una volta di più quali zone di buio, di opacità, di nebbia la società contenga al suo interno, nel bel mezzo della sua “normalità”. Di qui il coinvolgimento necessario e assolutamente prioritario delle famiglie per combattere la disponibilità alla droga, che in realtà è una lotta contro il “buco nero” che la società contiene al suo interno. Ben sapendo che se ne esce soltanto se uno crede in se stesso,e ciò avviene soltanto se molti gli stanno vicino, pronti ad aiutarlo senza sostituirsi a lui. Nelle nostre famiglie, dicono i ragazzi, se pretende amore dagli altri e si dice: “se così non è, non mi vogliono bene”. Ecco, l’inizio dalla fuoriuscita dalla droga c’è quando uno impara a chiedere prima di tutto a se stesso ciò che prima pretendeva dagli altri. Anche se una cosa, dice Valerio, è sempre difficile e ci fra tremare come bambini spaventati: “chiedervi di volermi bene”.
Nella “casa rossa” della comunità, genitori e figli imparano – si può dire per la prima volta! – a farlo assieme. Ed è il primo passo verso la salvezza, degli uni e degli altri. Infatti non ci si salva mai da soli.
4 – Varrà la pena, a questo proposito, di sviluppare una considerazione non marginale. Da sempre, i rischi e le ipoteche che gravano sulle comunità terapeutiche in genere sono quelli di presentarsi come un semplice sostituto della famiglia mancata, un’isola in cui costruire una felicità altrimenti impossibile. Dunque, una funzione prevalentemente, se non meramente, protettiva e “consolatoria”. Non c’è bisogno di richiamare, per dimostrarlo, il largo uso di un linguaggio di tipo familiare e i riti tipici della vita familiare che sostanziano le interazioni quotidiane nella comunità esaminata. Ma questo clima familiare, la sua organizzazione e divisione del lavoro e del tempo sono per così dire aspetti “naturali”, di per sé positivi. Il problema della comunità è un altro. E’ quello di non ripetere una struttura interattiva che mantiene l’individuo nella dipendenza, proteggendolo in una sfera appartata che è efficace solo finché ci si sta dentro.
Sotto questo aspetto l’esperienza in esame presenta un indubbio valore positivo, in quanto è pienamente avvertita del rischio e cerca di superarlo. Il “progetto uomo”, infatti, è tutto finalizzato a creare nella persona quel senso di fiducia in sé e nella vita, quella capacità di autocontrollo e padronanza che permettono al giovane di reinserirsi nella società intesa come “Gesellschaft” fatta di processi dissociativi, non meno che associativi, senza annullare la propria identità. E’ una vecchia dialettica, questa tra comunità ( Gemeinschaft) e società (Gesellschaft) che le società contemporanee devono riscoprire, e che le comunità terapeutiche come quella di Castelgandolfo contribuiscono notevolmente a chiarire. Ma restano dei nodi cruciali da risolvere.
Dice Germana: “Siamo qui perché non c’è alcun rifugio dove nasconderci da noi stessi. Fino a quando una persona non confronta se stessa negli occhi e nei cuori degli altri, scappa. Fino a che non permette loro di condividere i suoi segreti, non ha scampo da questi. Timoroso di essere conosciuto, né può conoscere se stesso né gli altri, sarà solo. Dove altro se non nei nostri punti comuni possiamo trovare un tale specchio?”. La comunità è dunque principalmente un luogo e una metodologia di riflessività, il mezzo attraverso cui ogni persona può aprirsi e fare i conti con se stessa, rispecchiandosi negli altri. Una struttura discorsiva di piena reciprocità. Niente trattamento di “esperti” o “specialisti”, niente “trattamento intensivo” alla N. Luhmann, ma costruzione di una rete di aspettative, atteggiamenti, valori, comportamenti tra gli stessi appartenenti alla comunità sulla base del mutuo aiuto. “Stai guardando quelli che sono davanti a te? E’ come una catena fatta di tanti anelli, una cordata, quello più avanti aiuta gli altri, ma anche quelli indietro sono utili ai primi…” ( don Mario). L’identità si costruisce guardando all’uomo che è “in noi”.
5 – Esistono due modi prospettici di affrontare il problema umano e sociale della tossicodipendenza, oggi, per tacere di quelli puramente repressivi o permissivi che non offrono alcuna prospettiva. Il primo è quello di considerare i “drogati” come vittime in qualche modo inevitabili di un certo processo storico, lo si chiami “modernizzazione”, “consumismo” o “capitalismo avanzato” e così via, che crea nuove subculture della morte e nuove multinazionali dello sfruttamento puro dell’uomo sull’uomo. Se non si reagisce con un appello a qualche sorta di rivoluzione politica che rimetta in causa tutti i rapporti sociali e le strutture del potere, il che può sempre accadere, per quanto non sembri una strada percorribile ( r invero una “non soluzione”) il modo più comune di reagire – ancor oggi – è quello di considerare i tossicodipendenti come vittime degne di compassione e di un po’ di assistenza ( così la chiamano i politici e gli amministratori), se non altro perché sono i mezzo a noi. Se riescono a venirne fuori, tanto meglio per loro e per la società. Se non ci riescono, è un destino fatale, purtroppo, quello che si abbatterà irrimediabilmente su di loro. E tutto quello che la società può fare è difendersi dai processi disgregativi che tale fatalità comporta. Anche le comunità terapeutiche sono utili a questo fine, e di qui la loro (retorica) esaltazione.<per questa strada si creano comunità terapeutiche che favoriscono la dipendenza, mantenendo i ragazzi coinvolti in un specie di quarantena.
Il secondo modo prospettico di affrontare il problema è invece quello di considerare il tossicodipendente , appunto, solo ed esclusivamente come “un uomo che ha un problema in più”, una vittima, forse, anzi certamente nella maggior parte dei casi, ma senza vittimismo. E’ comunque un fatto generale, generalissimo e sempre “generalizzabile”. Il tossicodipendente non è una vittima più di quanto non lo siano i genitori, così come ognuno di noi che non ha mai veramente amato, né compreso la vita. Si tratta allora di edificare una cultura delle relazioni umane e di servizio, che strutturi non solo le comunità terapeutiche, ma anche e soprattutto le famiglie ( il 95% della popolazione, in Italia, vive in una famiglia) come comunità di comunicazione dotata di piena reciprocità di scambi, dove, assieme al massimo di trasparenza e di chiarezza di rapporti, c’è un pieno rispetto e amore dell’uomo che è in noi. Questa è la strada imboccata dalla comunità di Castelgandolfo, che punta ad una maturazione delle persone coinvolte ( anche quelle esterne, sebbene forse non ancora nella misura auspicata) tale da creare autentici legami di amore, non di dipendenza. Scambi vitali, non chiusure o ricatti, anche sotto forma di richiami affettivi. Lo testimoniano molti punti del rapporto della Boggio, e soprattutto la metodologia di “gestione dei sentimenti” che viene descritta nel capitolo III. Nella comunità è più che ovvio che si ripresentino le strutture interattive “perverse”della società, come la tendenza al doppio legame ( il “double bind” di cui parla G. Bateson).Dice Germana: “Io delle volte mi trovo che non so che fare. Certe volte arriva Fabrizio dicendomi: ‘Prendi iniziative ’.Mi trovo a prenderle e mi si dice: ‘ che iniziative prendi?devi prima chiedere ’. Io delle volte non so che fare, Fabrizio!Mi sento sballottata da una parte all’altra, una pallina da ping pong. Mi si confronta su cose allucinanti che non ho fatto; le persone bussano, entrano, posano i vassoi, io neanche le vedo perché magari sto di spalle, e i cazziatoni me li prendo io. Angelo, mi dici: ‘ devi parlare durante il giorno, devi confrontarti perché sei chiusa ’. Quando parlo?Quando mai hai detto: ‘ vai a fumare una sigaretta fuori ’, oppure: ‘come stai?’. Qualsiasi cosa, quando me l’hai detto? Non mi prendere per il culo, Angelo! Non mi ci prendere!”.
Ora, il tratto estremamente interessante della comunità in esame è che essa non intende risolvere questi processi relazionali perversi tramite utopie di tipo cognitivistico ( ad esempio la razionale “comunità discorsiva” di J. Habermas). Anzi, essa, senza per nulla rinunciare alla razionalità cognitiva, mette in primo piano la razionalità dei sentimenti come base della struttura di (piena) reciprocità. Si analizzi, in questa luce, il dialogo fra Lucrezia ed Ennio verso la fine del capitolo II. La vitalità dell’esperimento si può forse riassumere in questo, che è dai sentimenti e tramite i sentimenti, riconosciuti per la loro reciprocità, che può nascere una nuova razionalità, e non soltanto
una personalità meno debole nel gestire i rapporti umani. Solo così Leandro può arrivare a dire: “Per me le piante, non lo so, vivono, respirano.., Se tu le tocchi così, proprio gli trasmetti qualcosa, hai capito? Io avevo delle piante, dei fiori, gli facevo dei complimenti a loro”. E così, una sensibilità che può apparire puerile viene ad inserirsi in un piano razionale di legami e sentimenti comuni. “Dipende da te non tagliarti. Ci tagliamo a volte, tagliamo noi l’affetto che ci è stato dato. Devi volerlo però, ma devi anche sapere che hai un tesoro dentro, che è questo affetto che ti è stato dato, che non ti viene tolto per nessuna ragione. Se uno ti ha abbracciato, non può stare eternamente abbracciato con te: è “un segno”, un momento più intenso. E anche se siete separati, siete ancora uniti (Vittorio).Il risultato è che i giovani che avevano perduto ogni contatto con la realtà, tornano a vivere, e questo è il passo fondamentale verso il reinserimento sociale. Ma ciò non può avvenire senza difficoltà e traumi, che possono portare alla regressione, se la società non è lì ad aspettarli e ad accoglierli come soggetti di uno scambio simbolico e materiale “pieno”. Senza per questo voler fare della società una famiglia, il che sarebbe una pericolosissima utopia. Ma guardando piuttosto alla qualità umana degli scambi comunicativi, nella comunità, nei gruppi sociali esterni, e fra di essi, nella misura in cui si avvicinano o si allontanano dal paradigma della comprensione, vivida e attenta, di mondo vitale.
6 – le comunità come quella di Castelgandolfo sono e diventano così anche una denuncia verso l’incapacità della nostra società, cioè poi delle istituzioni “ufficiali” del cosiddetto benessere sociale, verso i tossicodipendenti, come verso tutti i “drop-aut”. In specie nelle fasi della terapia e del reinserimento, per le quali vengono apprestati quei complessi “burocratico-industriali” che sono sempre più inefficaci e inadeguati. Dice Guido: “Veniamo da esperienze di strutture pubbliche!Abbiamo preso metadone, morfina, cioè prima sfruttavamo ogni possibilità di trovare droga da qualsiasi parte… Siamo passati da un ricovero in ospedale in cui venivamo curati con il metadone… a un tentativo da parte di uno psicologo… Soprattutto il ricovero in ospedale non mi dava niente, cioè non mi riempiva dentro. Poi uno ci aveva l’orario fisso, andava in quel determinato posto a prendere il metadone e, bene o male, aveva tutto il tempo per svolgere altre azioni, nel senso di trovare altri mezzi per andarsi a bucare. Più che altro era un mezzo per stare tranquilli, per non avere i dolori, alzarsi e non avere i sudori o meno, ma non c’era intenzione di smettere veramente”. La denuncia della simulazione e della ipocrisia non potrebbe essere più chiara. L’incapacità terapeutica dei servizi sanitari e sociali attuali è ovvia perché la nostra società sempre meno considera rilevante e trattabile il problema del senso, della vita interiore (“di dentro”, dicono sempre questi ragazzi), dell’intenzione che non può essere materializzata. Ma questa incapacità denuncia al contempo la difficoltà specifica di cui dicevo più sopra, e cioè quella di come atteggiarsi e rapportarsi con queste comunità, il cui momento più delicato è proprio quello del rapporto con l’esterno, in particolare quando il ragazzo deve trovare un lavoro e costruirsi la sua vita. Si rivelano quindi troppo facili le critiche a questi esperimenti, tutt’altro che di laboratorio, perché tenderebbero ad essere solo protettivi e consolatori. La verità è che non c’è riconoscimento sufficiente e pieno da parte non tanto della gente comune quanto delle istituzioni tipiche dello stato assistenziale, almeno del welfar state che conosciamo. D’altra parte nessuno ignora che anche i servizi socio-sanitari hanno bisogno di queste comunità e di fatto se ne servono largamente. Ma il punto è che non le “comprendono” a fondo, perché è difficile costruire una nuova cultura comune di vita. E ancor più difficile è relazionarsi con un buon grado di coordinamento.
La speranza è che libri come questo contribuiscano a far capire che, di fronte a crescenti impulsi distruttivi, a nuove stanchezze, depressioni e implosioni, è possibile instaurare un nuovo dialogo fra strutture pubbliche e private, o meglio di mondo vitale, perché tutti possano aprirsi a un nuovo mondo della vita. Infatti è da esperienze liminali come questa che la cultura umana, pur differenziandosi, trova nuove sorgenti di integrazione non convenzionale e non simulata.
Luigi M. Lombardi Satriani
La chiusa opacità del mondo
“Mi dovete aiutà! Non riesco... non riesco... Non riesco a buttarlo fuori!... Sto male!... Non ci riesco... Ho un’angoscia... non ci riesco... Come cazzo ve lo devo dì... Voglio qualcosa!... Fabrizio me devi aiutà!... Giuloiana me devi aiutà, me devi... Sono stato male una vita, capito?! M’avete rotto il cazzo... Ma come ve lo devo dì?!... Me devi aiutà, Giuliana, Ugo, Fabrizio, me devi aiutà. Aiuto! Aiuto! Aiuto! “
Questa richiesta di aiuto da parte di Leandro v- un tossicodipendente che tenta di uscire dal tunnel disperato della droga – ci presenta, senza mediazioni rassicuranti, una condizione drammatica, individuale e collettiva, e illustra, di fatto, le ragioni di questo volume.
L’efficientismo imposto dai modelli di vita dominanti non riesce a occultare del tutto la sempre maggiore improbabilità di reali rapporti intersoggettivi.
In anni ormai lontani, ma nei quali era “in nuce” ciò che si è dispiegato con corrosiva virulenza nei nostri giorni, Adorno aveva individuato alcuni dei sintomi della “paralisi del contatto”.
“Gli ordinamenti pratici della vita, che pretendono di giovare agli uomini, determinano, nell’economia del profitto, l’atrofia di tutto ciò che è umano, e via via che si estendono eliminano sempre più ogni delicatezza. (...) La parola diretta, che senza dilungarsi, senza esitare, senza riflessione, ti dice in faccia come stanno le cose, ha già la forma e il tono del comando che, sotto il fascismo, i muti trasmettono ai muti. La semplicità e oggettività dei rapporti, che elimina ogni orpello ideologico tra gli uomini, è già diventata un’ideologia in funzione della prassi di trattare gli uomini come cose”.
Questa gigantesca reificazione degli esseri umani si è accompagnata, nella nostra società, alla progressiva perdita di credibilità dei contenitori simbolici, che comunque rispondevano alla richiesta di senso; alla radicale attenuazione di tensione etica; all’ampliamento sino all’intollerabilità dell’insicurezza individuale e sociale,; allo smarrimento degli scopi cui orientare le azioni. Il mondo diventa, così, sempre più inabitabile; alla sua opacità corrisponde la frantumazione dei comportamenti individuali, spezzoni irrelati che non dicono altro che disperazione e senso di inutilità.
Tutto ciò si abbatte con particolare intensità disgregatrice sul mondo giovanile che, anche in quanto più “esposto” , subisce l’attrazione della droga, percepita da un numero crescente di giovani come liberatrice e risolutrice. Percezione totalmente illusoria – è appena il caso di ribadirlo – ma che viene pagata con un costo di vite umane e di sofferenza che suscita sgomento.
Certo, si tratta di alcuni, di molti, di moltissimi e non di tutti i giovani; certo, in ogni caso di tossicodipendenza, si attua un incontro tra condizioni generali predisponenti e situazioni indivduali, ma il dolore e la morte che i tossicodipendenti testimoniano, con il loro omicidio differito e con tutto ciò da cui fuggono, non sono per questo meno reali.
Ugo, in altra parte di questo volume, afferma: “Quando io giravo per strada, e vedevo un ragazzo e una ragazza che stavano insieme, che sorridevano, che prendevano un gelato, li vedevo contenti – capito, Vittorio? -, cioè proprio contenti; vedevo che passeggiavano, e per me non c’era questa cosa, nun ce stava... (...) Ci ho provato ( piange).Non c’è stata mai e, non lo so, allora l’unica cosa che ho voluto fare, alzamme dal letto è stato più forte di me, anda’ dentro al bagno e prende quella lametta... e vedé il sangue mio che usciva e poi costringermi a aspettà. Piano piano sentivo la vista che me se appannava e ci avevo paura... (piange).Sentii che nun ce stava più gnente... Sentivo la vista che s’appannava e sapevo che nun ce stava più gnente nella vita per me...”.
Riflettendo su quanto, con l’autenticità della sofferenza, i tossicodipendenti ci comunicano, ci accorgiamo che loro si costituiscono, singolarmente e globalmente, come risposta. All’invivibilità della vita, alla chiusa opacità del mondo, al silenzio degli altri, alcuni, troppi – e sarebbe troppo anche se fosse soltanto uno – rispondono con una “scelta” di morte.
Ma proprio perché risposta, tragica, i tossicodipendenti si costituiscono, singolarmente e globalmente, come domanda.
Domanda di cosa fare con loro per loro. Domanda che non possiamo eludere, con tecniche più o meno furbesche, perché è domanda radicale, rivolta a tutti e a ciascuno di noi.
E ciascuno di noi è chiamato a rispondere, se vorrà, tentando di disporsi secondo verità e non secondo potere.
Questo libro è una delle risposte, con il suo valore di testimonianza.
Maricla Boggio si è accostata con attenzione, intelligenza e amore alla comunità terapeutica di Castelgandolfo, realizzata da Mario Picchi e dai suoi collaboratori, nella quale, secondo la metodologia di Daniel Casriel adattata alla specificità della società italiana, molti giovani si allontanano col sostegno reciproco, comunitario appunto, dall’universo della droga nel quale erano precipitati.
Realtà da conoscere, ché se le analisi sono necessarie, esse si devono concretare in iniziative, perché sui tossicodipendenti non si faccia solo discorso e perché lo slancio amoroso non resti irrelato, come, in questo nostro tempo di afasia e di paralisi, sembra essere condannato a restare.
Alla fine del volume le parole di Valerio, nella loro eloquente semplicità, ci consegnano una richiesta che attraversa il libro e lo trascende: “... Una cosa per me è sempre difficile, e tremo come un bambino spaventato: chiedervi di volermi bene”.
Juan Corelli, vicepresidente del Ce.I.S.
Progetto uomo
“La casa dei sentimenti – itinerario per uscire dalla droga” è storia di vita dei nostri giorni e quindi anche di vita dilaniata e spezzata dalla tossicomania, ma soprattutto è storia della speranza dell’uomo, della sua volontà di resurrezione nella riscoperta profonda e vissuta del proprio essere.
Se vogliamo, possiamo dire che questo libro racconta l’eterna lotta tra l’essere e l’avere, dove i simboli, i riti, le strutture sono gli strumenti che vengono usati per mettere in luce modelli e valori capaci di dare un senso alla vita.
Il programma terapeutico è uno stralcio di vita rivissuta nel passato, quando la droga ne aveva ferito il tessuto esistenziale, e riemergente nel presente in una dinamica risalita verso la luce. Quindi, un programma dinamico che, a distanza di qualche tempo, già denuncia un passato che è remoto, perché nuove situazioni emergono, e la lettura della vita dell’uomo denuncia un oggi che è già proiettato nel futuro.
“La casa dei sentimenti – itinerario per uscire dalla droga” va letto quindi come un documento vivo, aperto al divenire.
Ogni giorno s’impongono nuove modifiche alla struttura del programma, perché ogni giorno la domanda è diversa e la risposta deve tener conto di situazioni socio-ambientali e culturali diverse. L’ “accoglienza” – nata ieri quasi solo ed esclusivamente come un breve momenti di mutua conoscenza tra l’utente e l’operatore – acquista in prospettiva, anche per necessità contingenti, il valore di una ricerca – prolungata nel tempo – di motivazioni, di riflessioni, di scelte di vita e di orientamento per quello che potrà essere il futuro.
Importante in questa fase è il gesto di accogliere, la riscoperta di una responsabilità personale che non può più oltre essere delegata ad altri.
In futuro il modulo dell’ “accoglienza” , probabilmente per molti casi, esaurirà anche la necessità di un ingresso in comunità terapeutica, purché essa sia vissuta come un momento cosciente di una libera scelta fatta per affrancarsi dalla droga.
La “comunità” è, e rimane, un punto centrale del programma terapeutico; tuttavia già fin d’ora sono in corso esperienze collaterali e multiformi di comunità terapeutiche, diversificate e per il periodo di permanenza e per il “trattamento” in esse usato.
Anche “Progetto uomo” sta vivendo questo momento creativo, con la comunità detta “di riferimento” , non ancora in atto al momento in cui questo libro fu pensato.
Identico è il traguardo, “che il residente scopra la capacità di divenire protagonista della propria vita”, ricreando rapporti con gli uomini e le cose e rendendosi conto di essere capace di fare scelte libere senza alcun condizionamento derivante da un farmaco o da sostanza stupefacente.
Mai una realtà come questa è stata più dinamica, perché dinamica è la vita stessa dell’uomo. Il futuro delle comunità – come del resto già il passato – non sarà certo più relegato solo alle storie di droga, ma si aprirà verso orizzonti più vasti, a sostegno dei molteplici stati di disagio personale che ostacolano il cammino dell’uomo.
In questo senso il libro è un documento che segna un cammino, dove alcune orme sono state cancellate dal tempo ed altre rimangono perché sempre attuali, mentre nuove impronte testimoniano una crescita in atto.
Anche la fase del “rientro”, dovendo dare risposte molteplici per giovani provenienti da esperienze comunitarie diverse, ha assunto oggi caratteristiche poliedriche.
Accanto a questi tre moduli, l’ “Associazione famiglie” si sta oggi delineando in filoni diversi, perché le esperienze sono sempre più pressanti e richiedono, da parte delle famiglie, un diverso tipo di coinvolgimento.
Rimane, in tutta la sua realtà, la caratteristiche dell’auto-aiuto, che l’ “Associazione famiglie “ gestisce, come un positivo momento comunitario di incontri, tesi a rendere sempre più coscienti i membri del nucleo familiare, che si è dovuto confrontare con il tragico problema della droga.
Tuttavia, accanto a questo, sorge il modulo propriamente terapeutico, che coinvolge più direttamente e responsabilmente i singoli componenti della struttura familiare.
La “Scuola di formazione” poi, è il modulo che provvede alla qualificazione di quanti fanno la scelta di lavorare accanto al tossicodipendente.
Una scuola dove il dinamismo è quotidiano, perché diventa palestra nella quale affinare le proprie capacità di coinvolgimento in forma positiva, senza peraltro impoverirsi e piegarsi di fronte alla violenza della droga.
Abbiamo detto che è scontro fra l’essere e l’avere.
Agli operatori, con i corsi di orientamento, di qualificazione e di aggiornamento, viene proposto di divenire modelli capaci di esprimere quella speranza che l’autrice del libro, Maricla Boggio, ha respirato e vissuto nei giorni in cui è vissuta volontariamente immersa nella realtà del programma terapeutico “Progetto uomo”.
Oggi questa pagine sono riproposte al lettore, mi sembra, con l’intendimento di conoscere, vivere e condividere la gioiosa riscoperta della vita di tanti giovani passati attraverso la tragica esperienza della droga.
E’ quindi un libro di speranza, dono di Maricla Boggio a quanto sapranno riscoprire il profondo significato di una testimonianza che “contro la droga, la vita è possibile”.
Maricla Boggio
Un discorso sulla pelle
MARICLA . Che cosa rappresenta per te, oggi, un ragazzo tossicodipendente?
DON MARIO PICCHI - Un uomo che ha un problema in più. Non ha niente di diverso.
Credo di essere stata l’unica persona accettata nel “programma” del Ce.I.S. – Centro Italiano di Solidarietà – che fa capo a don mario Picchi, pur non essendo né tossicomane nè operatore. Mi ìhanno accolta come una di loro. Il programma non pretende di offrire la sola possibilità di riscatto dalla droga. Il traguardo che si pone va al di là della liberazione dalla tossicodipendenza.
Nel programma, il ragazzo ancora succube della droga si identifica con il ragazzo che ne va uscendo e aiuta il compagno a conoscere le sue debolezze attraverso un lavoro di gruppo: ciò comporta una graduale maturazione della personalità, che si concretizza in una progressiva assunzione di responsabilità nella vita comunitaria.
Questo procedimento di identificazione e di dialogo libera il ragazzo dalla solitudine e dall’angoscia, cause primarie della schiavitù del “buco”. Perché il problema riguarda soprattutto la mancanza di amore, l’isolamento, frequente nella famiglia e in genere nella società attuale. La droga permette l’illusione effimera della fuga dal disagio, òa è presto il nulla a invadere l’esistenza del ragazzo e a distruggerlo. “Se ci si rispecchia negli occhi e nel cuore di un altro ci si salva”, è una frase che viene detta spesso in comunità. Il cammino che vi si percorre è lungo, duro e complesso: “Non ti regala niente nessuno”, dice un ragazzo ad un altro in una riunione di un gruppo di lavoro “sui sentimenti”, ma riuscirci è una vittoria stupenda, è il trionfo della vita sulla morte.
Questo abbiamo cercato di raccontare, vivendo l’esistenza dei ragazzi nel corso delle varie fasi del “programma”.
Nessuno di loro ha avuto paura di mostrarsi anche nei momenti più difficili. Qualcuno, in comunità terapeutica, ha perfino proposto di rivivere situazioni emozionalmente scabrose ma didascalicamente essenziali, “per offrire un contributo agli altri che sono ancora in difficoltà”. Il risultato è quello di una espressività diretta, senza mediazioni di esperti o esemplificazioni enunciative. Un discorso sulla pelle. Ma niente di rubato a tradimento, ogni azione calcolata, discussa, scelta.
Ho girato più di ventidue ore di pellicola. I componenti della troupe hanno diviso con i ragazzi e con gli operatori deel programma ogni momento della giornata. Ne è venuto fuori un materiale ricco di indicazioni di vita, da cui ricavare numerose trasmissioni, se veramente si vuole riflettere su un tema di così delicata importanza sociale e tentare di contribuire a risolverlo sul piano individuale, al di là di quelle che sono le responsabilità del mercato della droga, problema che sta a monte del nostro discorso.
Nel corso delle riprese, ci sono stati momenti in cui ero tentata di intervenire nella situazione che stavo filmando, perchè sentivo la necessità di dare il miocontributo a quei ragazzi alla ricerca dise stessi, l’avevo sempre fatto da quando stavo con loro. Ma i ragazzi capivano che c’era per me un’esigenza di silenzio: dovevo rinunciare in quel momento al consueto dialogo privato con loro, se volevo fare il lavoro che avevo deciso, starmene accanto all’operatore e guardarlo soltanto, imponendomi scelte espressive e tecniche nel rispetto dello sforzo che facevano per esprimermi come se noi non ci fossimo.
Si andava poi a Cinecittà, a fine giornata, per vedere quello che avevamo girato il giorno prima. Venivano spesso con noi i ragazzi, curiosi di scoprirsi staccati dall’emozionalità del momento vissuto, come presi nel gioco del giudizio critico sulla situazione che da vita ormai era divenuta metafora, linguaggio “altro”.
Servì, anche questo discutere e guardare insieme, a capire che cosa significa collaborazione. Servì ad avere fiducia nel futuro e negli altri, partendo dla presente e da noi stessi.
